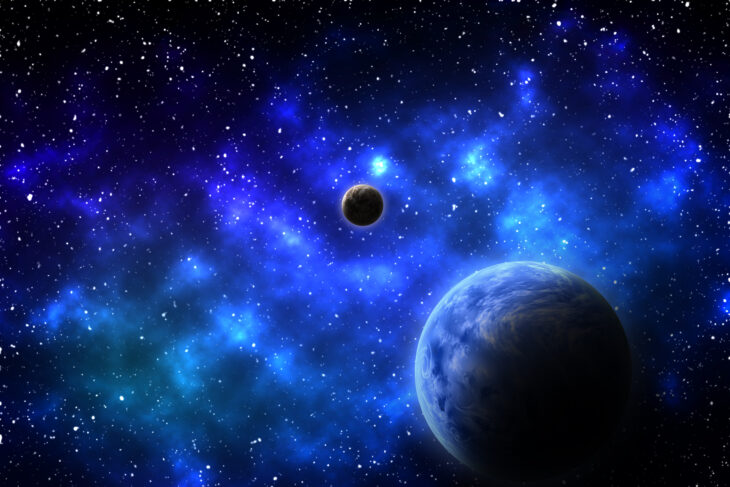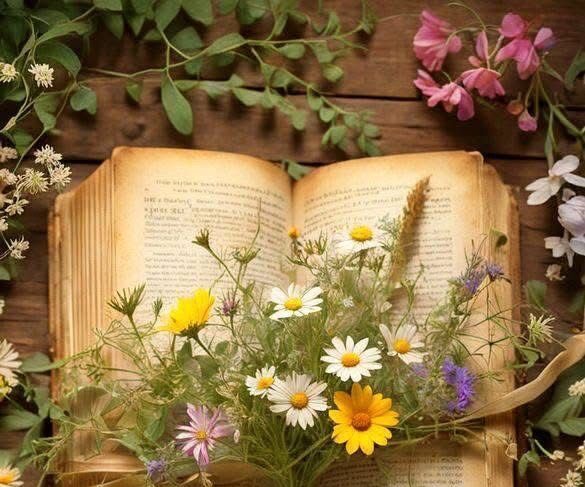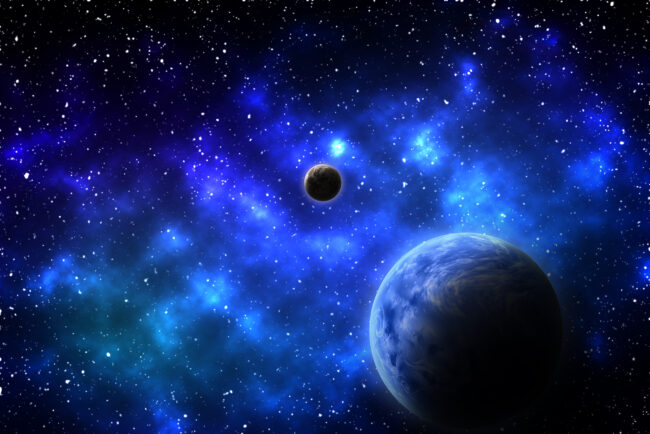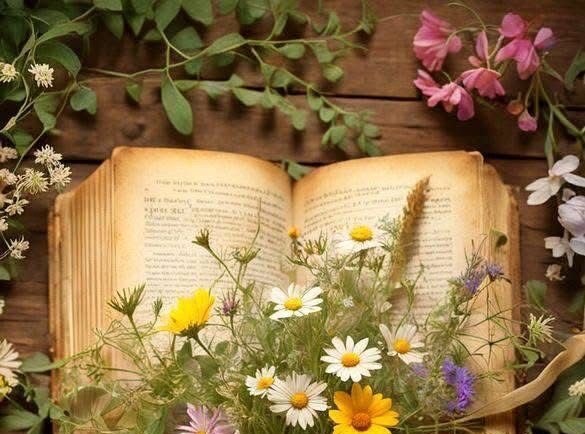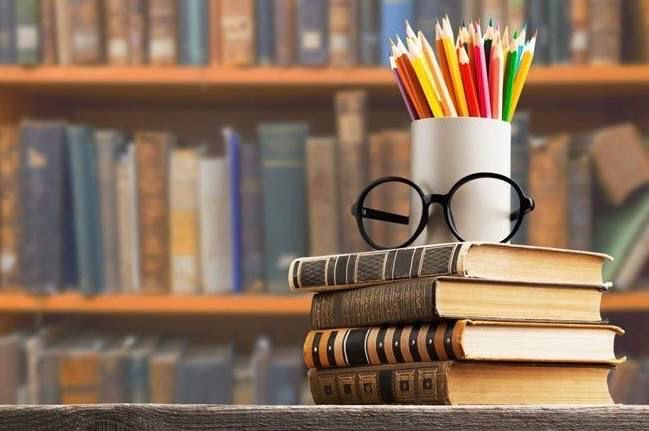
Tra stipendi fermi e prezzi gonfiati, i libri di testo trasformano il diritto allo studio in un affare per pochi.
Settembre, in Italia, non è soltanto il mese del ritorno a scuola: è anche il mese della resa dei conti per migliaia di famiglie. I libri scolastici, anziché strumenti di crescita e di conoscenza, si trasformano in un ostacolo economico, in una tassa occulta che pesa sul bilancio familiare quasi quanto una rata di mutuo o un affitto. È una trappola ben congegnata e, quel che è peggio, tollerata da tutti.
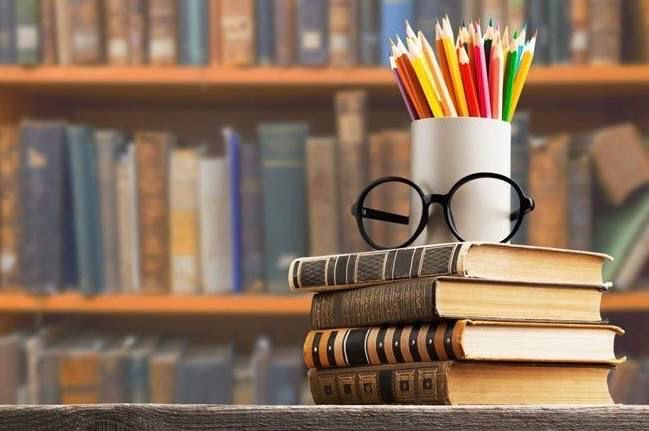
E il contesto in cui questo avviene è ancora più amaro. L’Italia è tra i Paesi europei con i salari più bassi e stagnanti, dove la crescita del costo della vita non trova alcun bilanciamento in stipendi adeguati. Famiglie che vivono già al limite si vedono imporre una spesa che può arrivare a rappresentare un decimo del reddito mensile, solo per mandare i figli a scuola. E quando i figli sono due o tre, la cifra diventa insostenibile.
Il paragone con l’Europa è impietoso. In Francia, Germania, Svezia, Finlandia i libri per la scuola dell’obbligo vengono forniti gratuitamente o gestiti attraverso sistemi di prestito pubblici. In Spagna, molte comunità hanno adottato modelli di prestito universale, garantendo pari opportunità a tutti. In Italia, invece, l’editoria scolastica continua a funzionare come una macchina che produce profitti senza sosta, a scapito delle famiglie. Qui non si tratta di garantire un diritto, ma di monetizzare una necessità.
Il punto è politico e culturale. Una democrazia avanzata non può permettersi di trasformare l’istruzione in un lusso. Non può consentire che un diritto universale venga piegato alle logiche di mercato. Non può lasciare che il futuro dei ragazzi diventi un bancomat per poche case editrici, mentre i genitori fanno i conti con stipendi fermi da vent’anni e un’inflazione che erode ogni margine. Eppure, anno dopo anno, governo dopo governo, la questione viene ignorata, come se fosse un dettaglio marginale.
Chi ci guadagna? Non gli studenti, che non imparano di più grazie a un indice spostato. Non i docenti, costretti a inseguire cambiamenti inutili. Non le famiglie, che si indebitano pur di rispettare un obbligo scolastico. I soli a beneficiarne sono gli editori, che hanno trovato la formula perfetta per trasformare la scuola in un affare miliardario.
E allora la domanda sorge spontanea: fino a quando accetteremo in silenzio questo racket mascherato da necessità didattica? Fino a quando considereremo normale spendere una fortuna ogni settembre per garantire ai nostri figli ciò che dovrebbe essere un diritto, non un privilegio?
L’istruzione è il fondamento di una società civile. Se diventa un peso insostenibile per molte famiglie, se si trasforma in un privilegio per chi può permetterselo, allora la scuola italiana tradisce la sua missione e mina le basi della nostra democrazia. Non bastano le denunce delle associazioni dei consumatori, non bastano le proteste delle famiglie: serve una scelta politica netta. Bisogna avere il coraggio di fare quello che altri Paesi hanno già fatto da anni, togliendo l’istruzione dal mercato e restituendola al bene comune.
Perché un Paese che tratta i libri come oro non sta investendo sul futuro: lo sta ipotecando.